
Le campagne di richiamo dei prodotti alimentari sono un tema molto delicato che coinvolge aziende, istituzioni e consumatori. Il Fatto Alimentare dopo una campagna di sensibilizzazione che si è conclusa con la decisione di otto catene di supermercati di pubblicare in rete l’elenco dei prodotti richiamati dal mercato, ha avviato un dibattito sulle criticità del sistema di allerta e sulle modalità di gestione dei ritiri e dei richiami da parte delle Asl, del Ministero della salute e dei magistrati. In queste pagine abbiamo esposto la posizione del procuratore di Torino Raffaele Guariniello, e abbiamo ospitato un intervento di Fabrizio De Stefani, direttore veterinario ASL ed esperto in sicurezza e diritto alimentare che pone l’accento su quale deve essere la soglia di pericolo da considerare per cui diventa necessario avvisare i consumatori.
Il nuovo intervento è quello dell’avvocato Giuseppe Giacovelli, esperto di diritto alimentare che propone una riflessione sul rapporto tra sistema di autocontrollo delle aziende, modalità di azione delle autorità nazionali, approccio comunitario e la filosofia alla base della vigente legislazione igienico-sanitaria alimentare italiana.
Il parere dell’avvocato Giuseppe Giacovelli
Il Reg. CE 178/02 che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione del settore, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e fissa procedure nel campo della sicurezza, ha inaugurato un processo di concentrazione della responsabilità in capo all’operatore del settore alimentare (di seguito OSA) per quanto attiene la sicurezza dei prodotti: difatti, spetta agli OSA garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte, in quanto tali soggetti sono “in grado meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti”.
Le disposizioni legislative prevedono un insieme di obblighi di conformità, tanto del prodotto quanto del processo produttivo, posti a tutela della salute pubblica e/o garanzia delle aspettative del consumatore. Gli obblighi imposti alle imprese dal Reg. CE 178/02 e sanzionati dalle legislazioni nazionali – in Italia dal D.Lgs. 190/06 – riguardano in particolare: l’obbligo di garantire che nelle imprese gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni sulla legislazione alimentare; l’obbligo della tracciabilità del prodotto alimentare, in funzione di un eventuale intervento delle autorità ove si accerti la pericolosità di un prodotto per la salute; l’obbligo di attivarsi per il ritiro dei prodotti a rischio che non si trovano più sotto il controllo immediato dell’imprenditore medesimo; l’obbligo dell’imprenditore di informare le autorità pubbliche ove ritenga o abbia motivo di ritenere che un alimento o mangime non sia conforme ai requisiti di sicurezza.
Gli obblighi di produttori e distributori
Primo tra gli obblighi incombenti sui produttori e distributori è proprio quello di garantire la conformità legale dei prodotti di cui essi fanno commercio.
All’interno di questo ampio dovere assume primaria importanza l’obbligo di immettere sul mercato solo “prodotti sicuri”, spettando ad essi garantire che gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione nelle diverse fasi. Il contenuto dell’obbligo di conformità qui in esame è da determinarsi avendo come riferimento i requisiti di sicurezza così come previsti dall’art. 14 del citato regolamento.
Gli alimenti a rischio
Nozione centrale per la nostra disamina è quella di alimento a rischio. Per determinare se un prodotto è a rischio occorre prendere in considerazione: le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.
A sua volta, la definizione di alimento a rischio si declina nelle due categorie: quella degli alimenti dannosi per la salute e quella costituita dagli alimenti inadatti al consumo umano.
Per determinare se un prodotto si deve considerare dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue: non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine sulla salute della persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; i probabili effetti tossici cumulativi; la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui sia destinato ad essa.
Invece, per determinare se sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
Il sistema di allerta
Con l’intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2008 sono state aggiornate le linee guida del 2005 per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano. Al paragrafo 3 si specifica che le nuove linee guida si applicano ogni qualvolta esista un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana, animale e la salubrità dell’ambiente, nei casi di:
- superamento nell’alimento o nei mangimi dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare;
- alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore (secondo quanto previsto dall’art. 14);
- mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall’art. 15 del Reg. CE 178/02.
Le medesime linee guida all’allegato D individuano una serie di casi in cui si identifica un grave rischio, la cui sussistenza legittima la notifica del rischio.
Il sistema del ritiro/richiamo nell’Unione Europea
Dal punto di vista degli obblighi gravanti sull’OSA si deve osservare che, certamente, le norme comunitarie ampliano i doveri di sicurezza ben oltre la fase in cui il prodotto è sotto il controllo del produttore: come recita l’art. 19 del Reg. CE 178/02. Al paragrafo 1 dell’art. 19 si stabilisce che, nel caso in cui l’operatore ritenga, o abbia motivo di ritenere, che un alimento in qualche modo passato nella sua disponibilità perché da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito ma non più sotto il suo controllo immediato, non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, tale operatore deve immediatamente avviare le procedure per ritirarlo e informare le autorità competenti.
L’obbligo di ritiro dell’alimento è quindi subordinato alla non conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza ed al fatto che lo stesso prodotto non sia più sotto il controllo immediato dell’operatore che prende coscienza e conoscenza della non conformità. Nella seconda parte del primo paragrafo si dispone poi che se il prodotto può essere arrivato al consumatore, lo stesso operatore che ha avviato le procedure per ritirarlo ha l’ulteriore obbligo di informare i consumatori in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e richiamare i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
La comunicazione del rischio
Sono individuabili due livelli di comunicazione sul rischio a cui l’operatore sottende. Il primo è una informazione obbligatoria rivolta all’autorità competente che si concretizza nel momento della consapevolezza della non conformità dell’alimento ai requisiti di sicurezza, e la seconda altrettanto obbligatoria che si compie qualora il prodotto non conforme fosse arrivato al consumatore finale ed è a quest’ultimo rivolta. L’obiettivo è garantire le condizioni per un pronto e puntuale prelievo dal mercato del prodotto non conforme e adeguata e rapida informativa alle autorità di controllo.
Sulla base della classificazione e dell’estensione del problema, nonché del momento in cui l’operatore si accorge o è avvertito della non conformità generata, l’azione da intraprendere può variare da un richiamo pubblico del prodotto al consumatore ad un ritiro del prodotto dalla distribuzione. Il dettato del secondo paragrafo dell’art. 19 si impegna nel delineare gli specifici compiti di quell’operatore responsabile dell’attività di vendita al dettaglio o distribuzione, cioè di quei soggetti che hanno soltanto indiretta responsabilità nella circolazione del prodotto insicuro (Aversano e Pacileo, 2006), con la caratteristica di non incidere sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento. Questo operatore ha l’obbligo di avviare procedure di ritiro dal mercato di quei prodotti non conformi, entro i limiti della propria attività, e di contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti fornendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi di responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti. Le predette disposizioni stabiliscono le regole generali che devono rendere possibile una efficace collaborazione tra i diversi soggetti della catena alimentare.
Le autorità competenti
Il terzo paragrafo dell’art. 19 individua una specifica situazione in cui l’operatore del settore alimentare può trovarsi qualora ritenga o abbia motivo di ritenere di aver immesso sul mercato un alimento che possa essere dannoso per la salute umana. In questo caso l’operatore deve informare l’autorità competente circa gli interventi adottati per evitare o ridurre i rischi al consumatore finale. Tale disposizione deve essere collegata con il disposto dell’art. 10 del Reg. CE 178/02 il quale prevede che l’autorità pubblica adotti a sua volta provvedimenti opportuni per informare i cittadini nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale.
Il dovere di informazione affermato dall’art. 10, deve contemperare l’esigenza di non creare inutili allarmismi, che tra l’altro potrebbero comportare comportamenti non corretti da parte del consumatore (Viti, 2003). Inoltre, ai sensi dell’art. 50.2 del Reg. CE 178/02 è fatto obbligo all’autorità competente, qualora … disponga di informazioni relative all’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, di trasmettere tale informazione alla Commissione nell’ambito del sistema di allarme rapido.
Gli operatori, nel caso di immissione sul mercato di un alimento dannoso per la salute, non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti. È con clausola di chiusura che si dispone, al paragrafo quarto dell’art. 19, che gli operatori del settore alimentare collaborino ex post, ossia a rischio ormai realizzato con le autorità riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito al consumo. Questa cooperazione collaborativa tra operatori ed autorità competente può riguardare anche la consulenza da quest’ultima fornita agli operatori che necessitano di conoscere in che modo gli obblighi debbono essere ottemperati ed a loro volta le autorità competenti devono prestare assistenza agli operatori qualora questi lo richiedano (Capelli et al., 2006): sono disposizioni queste ispirate al principio di lealtà ed effettiva collaborazione che pervadono tutto l’articolo 19 (Aversano e Pacileo, 2006).
Il sistema di ritiro/richiamo negli Stati Uniti, Canada, Australia e Cina[1]
Sul piano terminologico i termini di ritiro – withdrawal – e richiamo – recall – sono utilizzati nell’Unione Europea per definire la profondità dell’azione di ritiro lungo la catena alimentare. Manca, nel corpus normativo del pacchetto igiene europeo, una definizione legale di ritiro e/o richiamo. Il termine recall indica il ritiro di prodotti che sono a rischio mentre il termine withdrawal è utilizzato per individuare l’azione di ritiro di un alimento per motivi che non sono sanitari, legati per esempio alla qualità merceologica dell’alimento stesso. Sia negli Stati Uniti che in Canada il termine alert (allerta) è utilizzato nell’ambito dei richiami di prodotti alimentari che possono provocare allergie e/o fenomeni allergici.
Sul piano giuridico, se per gli operatori del settore alimentare della Cina e dell’Unione Europea, le azioni di ritiro/richiamo sono comunque obbligatorie, negli altri paesi il regime è prevalentemente volontario. In questi paesi sono le imprese stesse che decidono se procedere o meno ad una azione di richiamo, fermo restando la possibilità da parte delle autorità di definirne, qualora ve ne fossero i presupposti, l’obbligatorietà. Vale per tutti i paesi analizzati la tendenza al coinvolgimento, sia esso obbligatorio o volontario, di tutti gli operatori del settore alimentare.
Casi particolari
Una particolarità è rappresentata dall’Australia dove si impone l’obbligo di disporre di un piano di recall da parte di alcuni operatori e cioè grossisti, produttori e importatori, mentre l’azione di richiamo rimane su base volontaria. La volontarietà del sistema non esclude l’obbligo di informazione immediata dell’azione di richiamo all’autorità competente. Per quanto riguarda invece la comunicazione sul rischio rivolta al consumatore, nel modello europeo l’operatore del settore alimentare ne è responsabile in modo del tutto autonomo, a differenza del modello canadese e americano dove l’autorità competente coadiuva l’operatore nella fase di comunicazione. In Canada il messaggio oggetto della comunicazione sul rischio deve essere preventivamente valutato dall’Agenzia Canadese per la Sicurezza degli Alimenti nella forma e nei contenuti. Singolare nel modello cinese la previsione normativa che impone all’operatore l’interruzione immediata della produzione dell’alimento oggetto di richiamo.
Diverse sono le sfumature che caratterizzano invece il ruolo e le funzioni delle autorità competenti nei diversi modelli, tutti ispirati al principio della collaborazione. Le autorità competenti canadesi ed americane inoltre si fanno carico dell’informazione rivolta al consumatore, mentre nel modello europeo tale onere rimane a carico dell’impresa che ha attivato l’azione di ritiro e/o richiamo.
Nei sistemi del Nord America emerge inoltre il compito esperito dalle autorità, della valutazione qualitativa del tipo di richiamo in classi I-II-III a seconda della gravità dei probabili effetti nocivi sulla popolazione per il consumo degli alimenti soggetti al ritiro.
Ritiro e responsabilità dell’OSA
A seguito della notifica da parte dell’OSA del ritiro di un prodotto non conforme spetterà all’autorità sanitaria competente, se ravvisa, sulla base di una corretta valutazione del rischio, che l’alimento già presente sul mercato possa rappresentare un grave rischio per il consumatore, procedere all’attivazione del sistema di allerta. Questo significa che il sistema di allerta può essere attivato anche a seguito del riscontro in autocontrollo da parte dell’operatore di una non conformità del prodotto ormai immesso nel circuito commerciale.È indubbio che in quest’ultimo caso fondamentale importanza assume l’ autocontrollo aziendale.
 L’attuazione di un’azione sistematica di autocontrollo dei rischi igienico-sanitari, al fine di prevenirli e di fornire documentata verifica alle autorità di controllo, costituisce l’approccio scelto a livello comunitario ed attua una profonda innovazione, segnando (o avrebbe dovuto segnare!) il tramonto dell’attuale filosofia alla base della vigente legislazione igienico-sanitaria alimentare, che consiste nella mera applicazione di sanzioni amministrative e/o penali, qualora venga accertata una violazione di legge o di regolamento.
L’attuazione di un’azione sistematica di autocontrollo dei rischi igienico-sanitari, al fine di prevenirli e di fornire documentata verifica alle autorità di controllo, costituisce l’approccio scelto a livello comunitario ed attua una profonda innovazione, segnando (o avrebbe dovuto segnare!) il tramonto dell’attuale filosofia alla base della vigente legislazione igienico-sanitaria alimentare, che consiste nella mera applicazione di sanzioni amministrative e/o penali, qualora venga accertata una violazione di legge o di regolamento.
HACCP
Gli operatori delle industrie alimentari infatti sono chiamati ad una responsabilità diretta e prioritaria nei confronti dell’igienicità degli alimenti prodotti attraverso l’attuazione di due distinti fattori di prevenzione: l’adozione di un sistema scientifico di analisi dei rischi e monitoraggio dei punti critici del processo attraverso l’applicazione obbligatoria di cinque dei sette principi del cd. “metodo HACCP[2]”, nonché l’adozione di una serie di misure di corretta prassi igienica. Il “metodo HACCP” si fonda su una corretta attività di prevenzione dei rischi mediante l’individuazione a priori dei possibili pericoli connessi alla produzione di determinati alimenti (contaminazioni microbiologiche, chimiche, fisiche, deterioramento, ecc…) e l’adozione di opportuni correttivi che consentano di evitare la concretizzazione di tali pericoli. Inoltre, attraverso il monitoraggio continuo dei “punti critici” del processo produttivo, l’HACCP offre idonee garanzie di salubrità del prodotto finito. La corretta prassi operativa contempla l’adozione di pratiche e misure volte ad assicurare che i prodotti alimentari e le loro fonti vengano ottenuti in condizioni igieniche adeguate, l’adozione di misure relative a rischi provenienti dall’ambiente, il controllo dei contaminati, dei parassiti, delle malattie degli animali e delle piante, e l’obbligo di informare l’autorità competente qualora si sospetti di un problema in grado di nuocere alla salute umana. In un siffatto sistema è lasciato ai competenti servizi di prevenzione delle Az.Ulss il compito di verificare la corretta applicazione dei piani di autocontrollo.
Auto-incriminazione?
Come già anticipato, nel caso in cui l’operatore ritenga, o abbia motivo di ritenere, che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e non si trovi più sotto il suo controllo, tale operatore deve immediatamente avviare le procedure per ritirarlo e informare le autorità competenti. Ora, la comunicazione all’Autorità competente dell’esistenza di una procedura di ritiro del prodotto per una non conformità tale da determinare un rischio per il consumatore potrebbe portare ad una sorta di auto-incriminazione[3] per l’operatore alimentare nelle situazioni in cui tale non conformità possa assumere rilievo penale. E ciò perché in tutte le situazioni in cui il personale sanitario venga a conoscenza di casi che possono presentare i caratteri di un reato perseguibile d’ufficio diviene un obbligo effettuare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Ma allora, in caso di ritiro, al di là dei prevedibili risvolti in tema di responsabilità civile dei quali si tralascia in questa sede la disamina, l’OSA può essere chiamato a rispondere anche in sede penale? E se sì, quali sono le ipotesi di reato che possono essere addebitate all’operatore del settore alimentare?
Tutela della salute
Occorre premettere che le norme che regolano la materia alimentare sono poste a tutela di due beni fondamentali: la salute pubblica e la buona fede del consumatore. La tutela dei due beni fondamentali appena richiamati viene garantita dal sistema attraverso sanzioni di tipo strettamente penale nonché da sanzioni di natura amministrativa pecuniaria. Si sono così individuati due livelli di protezione. Un primo, generale, livello di tutela, consistente nelle norme del codice penale, che sanzionano i delitti contro la salute pubblica e i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. I delitti previsti nel codice penale consistono segnatamente nelle fattispecie di frode nell’esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previste rispettivamente dagli artt. 515, 516 e 517 del codice penale. Un secondo livello di cui alla Legge n. 283/1962 e articolato su contravvenzioni concernenti, genericamente, tutte le sostanze alimentari e tutte le fasi dalla produzione alla distribuzione.
Le norme rilevanti
Tralasciando la trattazione dei reati previsti dal codice penale, soffermiamoci sulle contravvenzioni previste dall’art. 5 L. 30 aprile 1962 n. 283 che solitamente vengono contestate nel caso di attivazione di un sistema di allerta.
L’art. 5 così recita: “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi o regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione”..
e) soppressa dall’art.3 L. 26 Febbraio 1963 n° 441;
f) abrogata dall’art. 57 L. 19 Febbraio 1992 n° 142;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengono residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministero per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo.
Reati di pericolo
Si tratta di fattispecie di reato che sono state costruite dal legislatore come reati di pericolo. A differenza dei reati di danno che si configurano quando l’offesa si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, nei reati di pericolo l’offesa è rappresentata dalla probabilità del danno. Dal punto di vista politico – criminale, tale ultima categoria di reati implica un’anticipazione della tutela, dato che si protegge un determinato bene giuridico per il sol fatto di essere stato messo in una situazione di potenziale pericolo. Per l’integrazione delle fattispecie criminose sopra citate non è necessario il “dolo”, ossia la coscienza e volontà della condotta, ma è sufficiente la “colpa” derivante dall’omissione dei doverosi accertamenti di conformità che avrebbero evitato il fenomeno vietato. Escluse le prescrizioni contenute nella lett. a), che sono di natura prettamente commerciale, in quanto si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche che il prodotto deve contenere al momento della sua immissione in commercio, nelle altre ipotesi, non vengono punite solamente la produzione e la commercializzazione, ma anche la detenzione del prodotto, non solo nel luogo di vendita, ma anche al di fuori dell’esercizio commerciale come nel caso in cui, per esempio, la merce si trovi ancora in magazzino. Il reato si fonda sulla relazione di fatto tra soggetto e prodotto[4], relazione che non postula necessariamente una vendita, ma anche una semplice cessione a titolo gratuito.
Per la contestazione dell’art. 5 lett. b) sotto il profilo della condotta dell’autore «non occorre né la cessione, né la somministrazione né la produzione di un danno per la salute pubblica», ma è sufficiente la semplice detenzione di sostanze alimentari che per il luogo, per le condizioni ambientali, per il sistema di conservazione, per i recipienti, contenitori ecc., sono conservate in modo inidoneo a scongiurare il pericolo di una alterazione o insudiciamento del prodotto; e sotto il profilo del bene oggetto del reato, per la configurabilità dell’illecito non è richiesto che le sostanze alimentari siano variamente alterate o depauperate (situazioni sanzionate da altri precetti contenuti nell’art. 5 della legge in esame), ma è sufficiente che siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l’igiene e la commestibilità.
Danno per la salute
La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con sentenza n.11996 del 25 marzo 2011, ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di detenzione o vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b L.283/1962) non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto. Trattandosi, infatti, di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di tale danno o di deterioramento. La Suprema Corte ha, pertanto, incluso tale fattispecie di reato nella categoria dei reati di pericolo e non di danno, a volere intendere che risulta preminente la tutela del consumatore rispetto anche al mero pericolo di una cattiva conservazione di sostanze alimentari che ne alteri o deteriori le proprietà organolettiche, a prescindere dal concreto ed effettivo verificarsi dell’evento. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 5 lett. b) legge 283/62, la vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, poiché, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano cagionare il pericolo di un tale danno. Art. 5 lett. c). La disposizione che vieta la produzione e commercializzazione di alimenti con cariche microbiche nei limiti superiori a quelli prescritti, ha potuto trovare applicazione dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 327/80 che costituisce il “Regolamento di Esecuzione” della Legge 283/62.
I limiti
Lo stesso Decreto, determina la fissazione dei limiti; tuttavia anche le “Ordinanze Ministeriali” possono fissare limiti relativi alle cariche microbiche; ciò è avvenuto per esempio con l’Ordinanza Ministeriale dell’11 Ottobre 1978 in tema di latte, prodotti d’uovo, gelati e loro preparati. Trattasi di fonti tassative che non possono essere allargate oltre i casi previsti, pena la violazione del principio di “stretta legalità” di cui all’articolo 25 Cost. che non può in alcun modo essere trascurato avuto riguardo della natura della Legge 283/62 che prende in considerazione la salute quale bene tutelato dalla Costituzione stessa. In ogni caso, qualora non esista un’ordinanza specifica per un determinato genere, o comunque non vengano superati i limiti dalla stessa fissati, è possibile l’applicazione dell’articolo 444 del Codice Penale, tenuto conto che indipendentemente dalla carica microbica riscontrata, in un determinato prodotto, può comunque essere presente una determinata “patogenicità” .
Quanto alla fattispecie criminosa di cui alla lettera d), la giurisprudenza ha osservato che essa non riguarda solamente i prodotti destinati immediatamente alla vendita, ma anche le materie suscettibili di trasformazione in vivande, purchè presentino corpi estranei che ne alterino la purezza e l’igienicità. La locuzione legislativa “o comunque nocive per la salute pubblica” costituisce un’ipotesi autonoma di reato, qualora nella sostanza alimentare possano essere riscontati difetti che prescindono dal superamento delle cariche microbiche.
Una riflessione
Tuttavia, si impone una riflessione sulla portata dell’espressione “o comunque nocive” prevista della lettera d) dell’articolo 5 della legge 283/62. Invero, la portata di tale espressione dovrebbe assumere rilevanza penale solo se e in quanto connotate dalla “nocività” della sostanza alimentare («insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione»), ovvero dalla sua sicura attitudine ad arrecare danno alla salute del consumatore, mentre nella quotidiana applicazione della disposizione si dà spesso per scontato che ogni forma di “insudiciamento” equivalga alla “nocività” dell’alimento. Relativamente alla “nocività potenziale” è necessario rilevare che la recente giurisprudenza ha mutato in parte la propria interpretazione richiedendo che nel caso concreto sussista effettivamente una situazione di pericolo che permetta l’applicazione della norma[5], ovvero non basterebbe più l’enunciazione di principio di violazione della norma, ma il perché averla violata nella circostanza concreta abbia determina un pericolo!
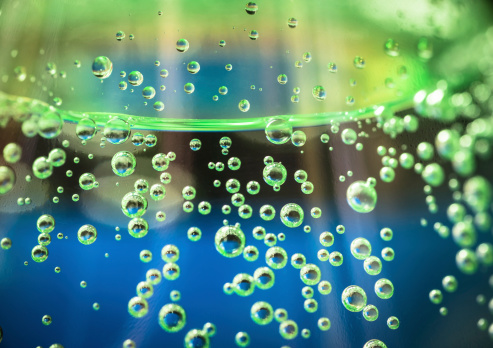 Pur essendo indiscutibile che la tutela della salute pubblica imponga l’osservanza rigorosa di una serie di cautele, vi sono situazioni obiettive in cui il rispetto della norma che vieta di commercializzare un prodotto che non sia stato previamente controllato non è in concreto esigibile o, quantomeno, non lo è con la medesima estensione. A questo proposito giova sottolineare che il c.d. “rischio zero” non esiste: per quanto infatti possa essere efficace il piano di autocontrollo, non si potrà mai avere la certezza al 100% di non porre in commercio prodotti alimentari irregolari. Infatti, anche utilizzando i più efficienti controlli, soprattutto nel caso della produzione di massa[6], può risultare impossibile la verifica di ogni singola unità del prodotto da immettere in commercio: va infatti tenuto conto che occorre comunque rispettare i termini di scadenza correlati alla natura dell’alimento e va inoltre considerato che ciò che è immune da vizi oggi, potrebbe non esserlo dopo un certo lasso di tempo. Il discorso vale in particolar modo per gli alimenti facilmente deperibili, ma si estende anche per quelle sostanze alimentari che possiedono specifiche caratteristiche organolettiche e altre qualità tipiche che potrebbero essere compromesse dalla necessità di eseguire minuziosi e continui controlli.
Pur essendo indiscutibile che la tutela della salute pubblica imponga l’osservanza rigorosa di una serie di cautele, vi sono situazioni obiettive in cui il rispetto della norma che vieta di commercializzare un prodotto che non sia stato previamente controllato non è in concreto esigibile o, quantomeno, non lo è con la medesima estensione. A questo proposito giova sottolineare che il c.d. “rischio zero” non esiste: per quanto infatti possa essere efficace il piano di autocontrollo, non si potrà mai avere la certezza al 100% di non porre in commercio prodotti alimentari irregolari. Infatti, anche utilizzando i più efficienti controlli, soprattutto nel caso della produzione di massa[6], può risultare impossibile la verifica di ogni singola unità del prodotto da immettere in commercio: va infatti tenuto conto che occorre comunque rispettare i termini di scadenza correlati alla natura dell’alimento e va inoltre considerato che ciò che è immune da vizi oggi, potrebbe non esserlo dopo un certo lasso di tempo. Il discorso vale in particolar modo per gli alimenti facilmente deperibili, ma si estende anche per quelle sostanze alimentari che possiedono specifiche caratteristiche organolettiche e altre qualità tipiche che potrebbero essere compromesse dalla necessità di eseguire minuziosi e continui controlli.
La responsabilità penale
La definizione della responsabilità penale del rappresentante di un’impresa alimentare deve, dunque, misurarsi con la delineata difficoltà di rispettare, in ogni condizione, la regola del controllo preventivo degli alimenti. La ragione per la quale vengono addebitare responsabilità penali agli OSA in caso di attivazione di allerta risiede appunto su due ordini di motivi.
Il primo motivo è di ordine politico-criminale e in un certo senso già anticipato: le fattispecie di reato di cui alla Legge n. 283/62 essendo reati di pericolo intendono fornire una tutela preventiva al bene salute, andando a colpire fattispecie che ne possano compromettere in qualche modo la integrità. Secondo motivo è che, a seguito della depenalizzazione di una serie di reati, le fattispecie previste dall’art. 5 L. n. 283/62, sono diventate ancora di più il punto di riferimento “penale” per gli organi di controllo. Il che non dovrebbe poi sorprenderci più di tanto ove solo si rifletta che, nel nostro ordinamento processuale, questi controllori hanno anche la qualifica di organi di polizia giudiziaria e quindi, per formazione culturale e professionale, tendono a privilegiare questo ruolo a fronte e a discapito di quello, amministrativo, della “prevenzione.
 Tornando al quesito di quale responsabilità deve rispondere l’OSA in caso di ritiro del prodotto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17549 del 25 marzo 2010 ha affermato che i reati in materia di alimenti sussistono anche quando sia avvenuto il ritiro del prodotto non in regola con le norme igienico-sanitarie, ma già preparati e distribuiti per il consumo, in quanto detti reati si perfezionano anche con la sola preparazione e distribuzione per il consumo.
Tornando al quesito di quale responsabilità deve rispondere l’OSA in caso di ritiro del prodotto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17549 del 25 marzo 2010 ha affermato che i reati in materia di alimenti sussistono anche quando sia avvenuto il ritiro del prodotto non in regola con le norme igienico-sanitarie, ma già preparati e distribuiti per il consumo, in quanto detti reati si perfezionano anche con la sola preparazione e distribuzione per il consumo.
Sulla stessa scia la Cassazione con sentenza n. 2991 del 05/12/2012, rigettando la prospettazione difensiva secondo la quale non sussisterebbe il reato (nella specie art. 5 lett. d) e g) della L.n. 283/1962 per presenza di listeria monocytogenes oltre i limiti legalmente consentiti in salsiccia di carne suina) perché non vi sarebbero state conseguenze per la salute della persona, in quanto la merce era stata venduta senza allarme e senza lamentele, ha confermato quanto già costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le fattispecie di reato previste dall’art. 5 L.n. 283/62 sono reati di pericolo e non di danno e si perfezionano, tra l’altro, anche con la sola preparazione o distribuzione per il consumo di alimenti contenenti sostanze nocive.
Se questo è il panorama della giurisprudenza italiana, quale valenza deve attribuirsi per es. al piano di autocontrollo? Un efficiente piano di autocontrollo può costituire una scriminante per l’operatore del settore alimentare?
Nonostante qualche sporadica sentenza[7], la Cassazione con sentenza 5 aprile 2007, n. 19716, (inedita) ha affrontato la questione della validità del piano di autocontrollo dei prodotti alimentari in un caso in cui era stata accertata la presenza del batterio denominato Listeria monocytogenes in tramezzini al salmone posti in vendita. La sentenza invero si limita ad osservare che l’adottato piano di autocontrollo non era risultato idoneo ad escludere dalla vendita il prodotto contaminato, senza tuttavia indicare specifiche circostanze oggettive a fondamento del giudizio di insufficienza dei controlli attuati.
Con sentenza n. 25122 del 2.4.2008 la Cassazione penale è tornata nuovamente sul tema affermando che “la mera esistenza di un piano di autocontrollo non è sufficiente ad escludere la colpa del responsabile dell’impresa alimentare”. La Suprema Corte giunge ad affermare che proprio l’avere rinvenuto alimenti in cattivo stato di conservazione ovvero insudiciati o comunque in precarie condizioni igieniche (nel caso in esame si trattava di prodotti di pasticceria contaminati dal bacillo E. coli) è comprovante una cattiva osservanza del piano medesimo senza ulteriormente indugiare sull’idoneità o meno delle precauzioni poste in essere dall’imputato.
La Corte, con questa decisione, avrebbe di fatto “chiuso a qualsiasi ruolo scriminante dei piani di autocontrollo e affermato l’irrilevanza delle procedure di HACCP[8]. Ma un quadro del genere aprirebbe uno squarcio importante: se si affermasse il principio della inidoneità del piano HACCP ai fini dell’accertamento della penale responsabilità, quali stimoli avrebbe un OSA per applicare oculatamente un piano HACCP? atteso che al semplice accertamento di una non conformità conseguirebbe la sanzione penale?
Conclusioni.
Alla luce di queste considerazioni, sembra quanto ormai opportuno invocare una certa armonizzazione e adeguamento della legislazione italiana ai nuovi indirizzi ed istituti della normativa comunitaria in materia alimentare. Bisogna prendere atto che il piano di autocontrollo e le buone prassi igieniche, anche quando adottate ed applicate nei migliori dei modi, sono in grado di ridurre i rischi ma non di eliminarli.
Considerato che il rischio zero non esiste, forse è il momento per accogliere nel nostro ordinamento il concetto di rischio accettabile, ossia ragionevolmente tollerabile, come frutto di compromesso tra ciò che è certo, perché acclarato – dunque al di sotto della soglia di cautela, e ciò che si presenta incerto, perché sconosciuto e solo remotamente ipotizzabile, dunque al di sopra della soglia di cautela. Se al di sotto della soglia di cautela resta, comunque, lo spazio per misure preventive, è, invece, al di sopra di tale soglia che divengono necessarie le misure precauzionali, che sono, a tutti gli effetti, misure di gestione del rischio [9], necessariamente fondata su di una valutazione del medesimo che, se sufficientemente seria ed equilibrata, sottrae le misure stesse a qualunque sospetto di illegittimità[10].
Con tale ultima riflessione si è anticipata, implicitamente, un’altra considerazione, certo non marginale, sul principio di precauzione: il ricorso ad esso non può essere in nessun caso, ritenuto alternativo alla fase della valutazione del rischio, che nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare, è la prima delle tre fasi in cui deve articolarsi l’analisi del rischio.
La valutazione del rischio, unitamente all’autocontrollo aziendale, dovrebbero rappresentare gli argomenti su cui fondare la dialettica dei rapporti tra autorità di controllo e operatori alimentari, così come dovrebbero essere uguali le “armi in gioco”, considerando che l’organo di controllo esercita, di fatto, poteri e prerogative che sfuggono alla verifica degli altri attori coinvolti nella procedura.
Il sistema di allerta dovrebbe, pertanto, prevedere effettivi strumenti di tutela per gli OSA, tenendo anche presente i considerevoli danni economici e di immagine che possono derivare dall’adozione di procedure infondate, nella consapevolezza che una errata valutazione del rischio può avere effetti negativi non solo sugli operatori interessati, ma anche, più in generale, sul mercato. Per esempio prevedendo dei meccanismi che consentano all’OSA di poter effettuare un controllo tempestivo sulla correttezza delle valutazioni espresse e sulle determinazioni assunte dall’autorità di controllo attraverso la presentazione di memorie e documenti in grado di poter confutare le procedure adottare anche con riferimento alle problematiche di ritiro e/o richiamo del prodotto.
Così come si dovrebbe prevedere la possibilità di opporsi alle valutazioni ritenute erronee, rivolgendosi ad un organo tecnico terzo e imparziale, appositamente istituito, che nell’ambito di una procedura effettivamente veloce ed esauriente garantisse un controllo sulle determinazioni oggetto di critica. E questo in un momento precedente all’eventuale instaurazione di un procedimento penale. Invece, in taluni casi, questo controllo è impedito in quanto l’operatore non è messo in grado di conoscere le ragioni tecniche e giuridiche che hanno determinato l’organo emanante all’adozione dell’allerta.
 Oltre ad un intervento nella procedura di valutazione del rischio sarebbe auspicabile, infine, da parte del legislatore un aggiornamento della legislazione penale e in particolare una rimodulazione dell’art. 5 L. n. 283/62 in chiave di rischio e non di pericolo. Una tale modifica non significherebbe depenalizzare i reati alimentari quanto piuttosto ricondurli a fattispecie che abbiano riscontro con l’attuale disciplina della sicurezza alimentare, accentuando l’attenzione sulla perdita di controllo dei processi produttivi eliminando in questo modo l’avvio di procedimenti penali rivolti ad accertare responsabilità per fatti che hanno scarsa rilevanza ai fini della tutela della salute (es. larve di anisakis morte, cariche batteriche aspecifiche, salmonella in alimenti destinati alla cottura ecc.).
Oltre ad un intervento nella procedura di valutazione del rischio sarebbe auspicabile, infine, da parte del legislatore un aggiornamento della legislazione penale e in particolare una rimodulazione dell’art. 5 L. n. 283/62 in chiave di rischio e non di pericolo. Una tale modifica non significherebbe depenalizzare i reati alimentari quanto piuttosto ricondurli a fattispecie che abbiano riscontro con l’attuale disciplina della sicurezza alimentare, accentuando l’attenzione sulla perdita di controllo dei processi produttivi eliminando in questo modo l’avvio di procedimenti penali rivolti ad accertare responsabilità per fatti che hanno scarsa rilevanza ai fini della tutela della salute (es. larve di anisakis morte, cariche batteriche aspecifiche, salmonella in alimenti destinati alla cottura ecc.).
Avv. Giuseppe Giacovelli (già collaboratore e consulente dell’Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto)
[2] L’art. 5 reg. n. 852/2004 il cui 1° comma stabilisce per l’appunto che «Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP”.
[3] La problematica è già stata oggetto di ampio dibattito in dottrina. Secondo alcuni autori (Correra, Durazzo) l’obbligo comporterebbe una violazione del principio costituzionale del “nemo tenetur se detegere” (art. 24 cost.), in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale.
Altri (Aversano) rilevano, tuttavia, come la semplice informazione non possa essere equiparata alla self incrimination, anche perché “il retroterra dell’obbligo informativo non può riposare sulla commissione di illeciti penali”, e, su di un piano più formale, per il fatto che “il principio del nemo tenetur se detegere si applica come garanzia difensiva solo dal momento dell’avvio del procedimento penale”, e non anche, come nel caso di specie, in una fase prettamente amministrativa.
[4] Per Cass. 12 gennaio 2010,( Ced Cass., rv. 247489.), in un caso di merce prodotta per essere destinata al mercato degli Stati Uniti, l’integrazione della fattispecie criminosa non necessita della consegna del prodotto, in quanto il reato si consuma nel momento in cui la sostanza alimentare viene preparata e confezionata, pronta per essere consegnata; Cass. 25 marzo 2010, Ced Cass., rv. 247488.), in tema di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ha statuito che integra il reato la condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell’operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consumatori.
[5] in dottrina si è proposta una nozione lata di nocività come quid minus rispetto alla pericolosità. X sostanze comunque nocive devono intendersi quelle che possono creare concreto pericolo per la salute pubblica (Cass. VI, 27.4.94, proprio in un caso di contaminazione da mercurio oltre i limiti tollerati, decisione che ha infatti escluso il reato).
[6] Sulla responsabilità del grossista, ci pare da condividere la posizione espressa da Cass. 16 ottobre 2007, che, pur ritenendo che l’attività dei rivenditori all’ingrosso si caratterizzi per un volume di affari e per tempi di smaltimento dei prodotti che, in presenza di merci deperibili, non consentono sistematici e capillari controlli, proprio la presenza di un elevato volume d’affari e le caratteristiche del commercio svolto consentono al grossista la programmazione di forme di verifica della qualità della merce trattata e pertanto la sua responsabilità può essere esclusa solo ove, quantomeno periodicamente, siano stati eseguiti controlli a campione su ciascuna delle categorie di prodotti acquisiti per la rivendita o sia stata richiesta al produttore la prova di tali indagini (verifiche che, invece, non possono essere richieste al commerciante al dettaglio).
[7] Pretura di Pordenone: decidendo della responsabilità connessa ad una ipotesi di vendita di carne di suino risultata contaminata da salmonella, il giudice si è pronunciato per l’assoluzione dal reato di cui all’art. 5 lett. c) della L. n. 283/62 argomentando dalla corretta applicazione delle procedure di autocontrollo. I riscontri positivi dell’organizzazione imprenditoriale, l’elevato standard di procedure igieniche ivi applicate condussero il giudice “alla conclusione che non poteva ascriversi rilievo di negligenza o colpa in capo al prevenuto, in quanto egli aveva rispettato tutte le doverose regole di comportamento imposte dalla legge e dalla prudenza professionale”.
[8] Anche se comincia ad aprirsi un varco su questa tema. Tra le diverse sentenze riporto la n. 236 del 28.3.2011 del Tribunale di Terni per la quale non può essere “ascritto a responsabilità colpevole il rinvenimento di un insetto all’interno di una bottiglia di acqua minerale allorchè la società imbottigliatrice adotti un protocollo standard di costanti controlli di tipo qualitativo, mirati a monitorare la qualità del prodotto da un punto di vista microbiologico e chimico fisico dalla origine fino al prodotti finito, nonché ulteriori e continui controlli lungo la linea di produzione, e, da ultimo, anche controlli visivi e olfattivi del prodotto finito
M.Sollini, Il principio di precauzione nella normativa comunitaria della sicurezza alimentare, 2006. La concezione del rischio accettabile posta nei termini sopra detti risiede nella distinzione tra rischio reale (cioè certo, controllabile) e rischio potenziale che richiama a sua volta un’altra differenza, quella tra prevenzione e precauzione. Invero, la prevenzione agisce nell’ipotesi in cui i danni sono certi: infatti essa è orientata all’eliminazione o alla riduzione dei rischi noti, quindi dagli effetti prevenibili in quanto prevedibili. La precauzione agisce quando i danni sono solo largamente ipotizzati, quindi riguarda quei rischi ignoti che allo stato delle conoscenze attuali non si possono ragionevolmente escludere. In conclusione, la misura prevenzionale presuppone un rischio accertato del quale si vogliono scongiurare le possibili conseguenze dannose. La misura precauzionale presuppone un rischio soltanto temuto, sospettato o supposto.
[9]Il rischio accettabile è la risultante di un processo decisionale dell’autorità politica che dovrebbe consentire di valutare come e fino a che punto è ammessa una determinata attività, come e fino a che punto i pericoli ad essa connessi sono da ritenersi accettabili per una società.
[10]Il tribunale di primo grado (Sentenza Pfizer Animal Health, cit., punto 5 della motivazione) ha correttamente precisato che “la determinazione del livello i rischio reputato inaccettabile dipende dal giudizio espresso dall’autorità pubblica competente sulle particolari circostanze di ciascuna fattispecie. A tal proposito detta autorità può considerare, in particolare, la gravità dell’impatto della sopravvivenza di tale rischio sulla salute umana, ivi compresa la portata dei possibili effetti nocivi, la persistenza, la reversibilità o gli effetti tardivi eventuali di tali danni nonché la percezione più o meno concreta del rischio sulla base dello stato delle conoscenze scientifiche disponibili”.
© Riproduzione riservata
Foto: Photos.com





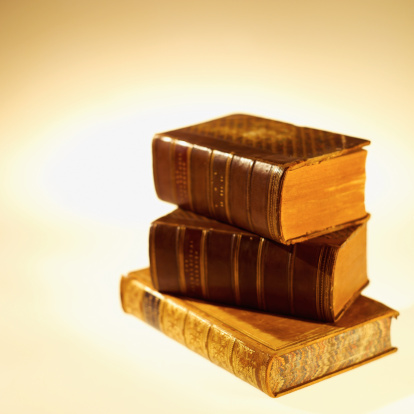










Finalmente una trattazione completa, serena, onesta e coerente di un tema a me caro (come a tutti gli OSA) che periodicamente ripropongo da oltre 10 anni nelle sedi più disparate, compreso IL FATTO ALIMENTARE : l’ASSOLUTA NECESSITA’ dell’adeguamento dell’OBSOLETO articolo 5 della legge 283 ,tramite sua riscrittura nell’ambito di un TESTO UNICO, ai principi e dettami della MODERNA legislazione CE.
Ora si acceleri “a tutti i livelli ed in tutte le sedi, e con tutti gli strumenti utili” per convincere i(finora riluttanti) ministeri competenti, ascoltando finalmente i suggerimenti di chi opera giornalmente con tante difficoltà sul campo , affinché IN UN TEMPO DEFINITO venga steso ed approvato un TESTO LEGISLATIVO SEMPLICE E CHIARO che ridefinisca in chiave europea tutta la materia e fornisca sicurezza interpretativa al diritto alimentare