
Dead Zone: dopo Farmageddon continua il viaggio attraverso le conseguenze ambientali dell’allevamento intensivo. Il safari virtuale tra le specie minacciate
Dead Zone: dopo Farmageddon continua il viaggio attraverso le conseguenze ambientali dell’allevamento intensivo. Il safari virtuale tra le specie minacciate
Paola Emilia Cicerone 4 Aprile 2017Gli allevamenti industriali sono crudeli, ma anche pericolosi per l’ambiente e per la biodiversità. Si può riassumere così il messaggio lanciato da Dead Zone (Nutrimenti, 2017) il saggio che Philip Lymbery, direttore di Compassion in Word Farming, ha dedicato al rapporto tra allevamenti intensivi e disastri ambientali. In oltre 400 pagine, Lymbery racconta un viaggio dedicato alle “Zone morte”, le aree del pianeta depauperate da deforestazione e coltivazioni intensive: un pellegrinaggio che spazia dagli elefanti di Sumatra, messi in crisi dall’estendersi delle coltivazioni di olio di palma, alla pianura padana dove non si vedono più animali al pascolo, passando per i vasti spazi degli Stati Uniti e del Brasile, gli insediamenti di pinguini in Sudafrica e altro ancora.
“Ci battiamo contro l’allevamento industriale, perché è crudele, ed è uno spreco, anzi, il principale spreco di cibo: confiniamo gli animali per nutrirli con alimenti che potremmo consumare noi, come pesce, soia o cereali”, afferma Lymbery, che abbiamo incontrato a Milano in occasione della sua partecipazione a BookPride. I dati sono impressionanti: sul pianeta ci sono circa 70 miliardi di animali da fattoria, allevati ogni anno per scopo alimentare, due terzi di essi in allevamenti intensivi. E per nutrirli si utilizza il 40% di tutti i raccolti.

“Solo un quinto del mais prodotto in Usa è destinato al consumo alimentare umano”. Senza dimenticare il palmisto utilizzato per mangimi per maiali e bovini, “aumentando il profitto delle aziende che producono olio di palma e danneggiando un ambiente unico al mondo”, scrive Lymbery che in Dead Zone cita la campagna de Il Fatto Alimentare contro l’olio di palma. “L’unione europea è il maggior importatore al mondo di farina di palmisto”, ricorda il direttore di CIWF. “Ora, è vero che le palme rendono molto, ma non tutti i territori hanno il valore biologico di quello che va perduto per estendere le coltivazioni di palma: quando ci chiediamo cosa c’entrano gli elefanti con la bistecca che mangiamo, ricordiamo che in una superficie di foresta di ampiezza pari a due campi di calcio c’è una quantità di biodiversità pari a quella dell’intero Regno Unito”.
Ma il problema è più generale. E Philip Lymbery, appassionato di ornitologia, spiega che una delle vicende che l’hanno colpito di più è quella dei pinguini del Capo che ha visto in Sudafrica, a rischio estinzione per l’eccessivo sfruttamento delle riserve ittiche: “Per produrre le farine di pesce usate per l’allevamento, si usano acciughe e altri pesci che potrebbero servire per l’alimentazione umana o per alimentare i pesci più grandi che poi mangiamo”, ricorda il direttore del CIWF. Mentre le monocolture indispensabili per produrre i mangimi destinati agli allevamenti intensivi sono responsabili della perdita di biodiversità. “Oggi non ci sono quasi più lombrichi, api, farfalle, non si sentono cantare gli uccelli, – denuncia Lymbery – senza dimenticare l’inquinamento delle acque, dovuto a fertilizzanti e pesticidi resi necessari dall’agricoltura intensiva”. Tradizionalmente gli animali della fattoria, soprattutto maiali e pollame, consumavano scarti alimentari funzionando come un efficientissimo sistema di riciclaggio: “Una soluzione ottimale, ma non piace alle aziende che producono mangimi, che fanno sentire il loro peso nel definire le politiche agricole”.

Anche se in Europa le cose vanno meglio che negli Stati Uniti: “Alcune delle pratiche più crudeli adottate dagli allevatori sono state eliminate, mentre negli Usa, dove in pratica non esistono leggi federali sul benessere animale, visto l’atteggiamento dell’attuale amministrazione i prossimi anni saranno durissimi” spiega Lymbery, tanto che l’azione di CIWF è ora rivolta soprattutto alle aziende, “che paradossalmente sono più sensibili delle istituzioni perché rispondono alle esigenze manifestate dai consumatori”.
Perché secondo Lymbery migliorare le cose si può: “dobbiamo mangiare meno carne, e puntare sulla qualità scegliendo produzioni locali e allevamenti in cui gli animali possono vivere all’aperto”. A chi dice che se allevassimo all’aperto bovini e polli non ci sarebbe spazio abbastanza, il direttore di CIWF ribatte che un falso problema: “Semplicemente non è vero: che senso ha tenere gli animali confinati, e utilizzare il terreno per coltivare soia e cereali usati per nutrirli?”. Non si tratta solo di benessere animale ma anche di uno sfruttamento inefficiente delle risorse , osserva Lymbery, che cita come esempio virtuoso gli animali al pascolo nei parchi dell’Abruzzo: “Ha senso che gli animali mangino ciò che noi non possiamo mangiare, come l’erba: uno studio dell’università del Minnesota mostra che ogni 100 grammi di proteine presenti nei cereali con cui nutriamo gli animali ci permette di ricavarne 43 dal latte, 40 dal pollame, 10 dalla carne di maiale e solo 5 da quella di manzo”.

Anche se non sempre agli animali alimentati correttamente è garantita anche una qualità di vita accettabile: “In Val Padana non si vedono mucche al pascolo”, conclude Lymbery. “È vero che gli animali che forniscono il latte per produrre Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono alimentate con erba, ma questo non significa che possano pascolare: nella stragrande maggioranza dei casi, anche gli animali degli allevamenti biologici rimangono nella stalla”.
Dead Zone di Philip Lymbery. Casa editrice Nutrimenti, collana Igloo. 456 pagine. Prezzo: 19.00 €
© Riproduzione riservata
Le donazioni si possono fare:
* Con Carta di credito (attraverso PayPal). Clicca qui
* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264
indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare. Clicca qui
giornalista scientifica

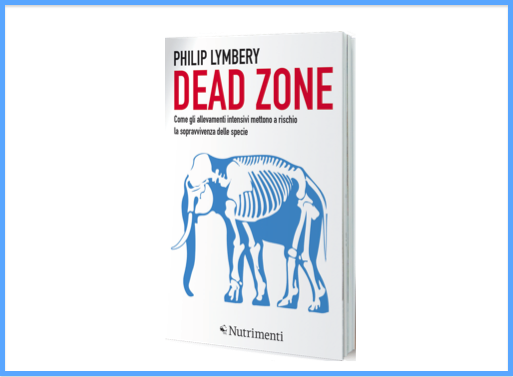







In natura quando si superano certi limiti di sopravvivenza, qualcosa cambia anche nell’inconscio collettivo.
L’avvento del veganesimo di massa, è un segno di questo cambiamento, iniziato con il vegetarianesimo meno diffuso ed ora esploso a valori riconosciuti e condivisi dal mondo occidentale.
Anche se non praticato da tutte le persone sensibili ai principi ispiratori, questi sono ampiamente condivisi da un numero sempre crescente di persone, che stanno sviluppando una maggiore coscienza consapevole del cibo che consuma e dell’ambiante che lo circonda.
Con tutti i limiti ed errori pratici dell’approccio, questo cambiamento sarà la vera ed unica risposta sociale ai problemi salutistici ed ambientali sostenibili nel prossimo futuro.